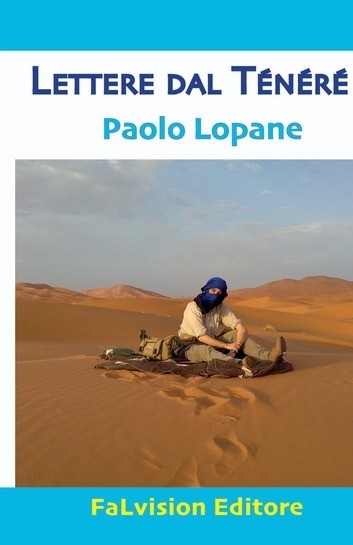Pubblicata in Dialoghi Mediterranei
Deserto, il grado zero dell’anima
di Francesco Medici
Un’antica leggenda che si tramanda tra le genti del Sahara narra che in un remoto passato, al posto di quell’immensa regione arida dell’Africa settentrionale che si estende attualmente per circa 5.000 chilometri di lunghezza e 2.000 di larghezza, alternando al suo interno paesaggi sabbiosi (erg), rocciosi (ḥammādah) e ciottolosi (serir o reg), vi era una sconfinata distesa verde, fresca e lussureggiante, ricca di corsi d’acqua e densamente abitata da popoli che vivevano felici e in pace. Dio avrebbe però raccomandato agli uomini di agire sempre secondo giustizia, altrimenti avrebbe lasciato cadere un granello di sabbia sulla terra per ogni loro empietà. Ma con il tempo essi finirono per perdere la retta via, dimenticando quel monito divino. All’inizio quasi nessuno si accorse dei primi granelli che andavano accumulandosi sul terreno, altri invece sottovalutarono quel fenomeno, ritenendo che ci sarebbero voluti milioni di anni prima che quella polvere leggera potesse arrecare loro qualche danno. Gli uomini iniziarono quindi a combattersi gli uni contro gli altri, tribù contro tribù, finché la sabbia seppellì rapidamente campi e pascoli, disseccò i ruscelli e spinse le povere bestie sempre più lontano in cerca di cibo. Perché gli esseri umani rimpiangessero la terra perduta e non dimenticassero le loro colpe, Dio punteggiò il deserto di radi e isolati palmeti, inoltre fece sì che di tanto in tanto, all’orizzonte, si presentasse allo sguardo dei viandanti, come in un sogno a occhi aperti, l’immagine illusoria di rigogliosi paesaggi ameni che oggi si suole chiamare generalmente miraggi. Anche il Profeta Muḥammad, fin dall’infanzia, deve aver udito raccontare questa leggenda, ed è probabile che anche per questa ragione, in contrapposizione alle tinte smorte e monotone dell’inospitale territorio desertico, volle che fosse il verde il colore rappresentativo della fede in Allāh, chiaro simbolo di quel Paradiso (termine che etimologicamente significa per l’appunto “giardino”) in cui ogni pio musulmano anela di entrare alla fine dei suoi giorni terreni.
Eppure, a dispetto di un adagio arabo secondo il quale «nessuno vive nel Sahara se può vivere altrove», è raro che il deserto venga percepito come un castigo da chi vi risiede. Ad esempio, per i Sahrawi – in particolar modo per i Tuareg – esso costituisce piuttosto una benedizione divina. Tutte e tre le religioni abramitiche sono nate infatti nel cuore del deserto, e si potrebbe peraltro aggiungere che i popoli autoctoni dell’area nordafricana, designati in Occidente come Berberi, non vedono assolutamente in quelle sterminate lande desolate una prigione cui Dio stesso li avrebbe condannati: lo dimostra il semplice fatto che nella loro lingua nativa essi si definiscano di contro Imazighen, “uomini liberi”, cioè abitanti di un territorio che è di per se stesso paradigma della libertà.
Per i ṣūfī, i mistici dell’Islam, il deserto rappresenta il grado zero dell’anima, cioè quello stadio cruciale di evoluzione interiore in cui la consapevolezza perviene a un vicolo cieco, ovvero a quella fase di profonda crisi esistenziale in cui non si intravede alcuna speranza e tutto appare privo di significato. Ogni consapevolezza deve inevitabilmente attraversare il deserto – il deserto dell’angoscia, della disperazione, dell’assurdità, del senso di perdita e di morte – per raggiungere la piena maturità: è insomma la tappa fondamentale e ineluttabile dello sviluppo spirituale. Ma come trascendere il deserto? Il fragile castello di misere certezze, faticosamente costruito nell’arco di un’intera esistenza, non potrà essere di alcun conforto. Occorre piuttosto abbandonare le proprie consuetudini, il passato, il conosciuto, per iniziare un viaggio all’insegna del nuovo, dell’ignoto. Il deserto bisbiglia, si dice, ma bisogna saperlo ascoltare. Ed è questa la quintessenza della meditazione: porsi in silenzioso ascolto del proprio Sé – quello che nel sufismo (taṣawwuf) si definisce “l’Io più grande” – per scorgere infine la luce.
Il deserto può insegnare la resa, far comprendere che non si può restare identici a se stessi, perché la vita è movimento e non è dato arrestarsi, avvinghiarsi ad alcunché, né tornare indietro. Soltanto allora quella crisi interiore si tramuterà fatalmente in un’imperdibile opportunità per una trasformazione radicale, a condizione di avere il coraggio necessario per mettersi in cammino, per rischiare ogni cosa. «Un uomo che rifiuta di conoscere il suo Dio, non è saggio abbastanza da
mettere piede nel deserto» – lo sa bene Adrien, protagonista di Lettere dal Ténéré (Falvision Editore, 2018) di Paolo Lopane, che nella premessa al volume dichiara: «attraversare in filigrana gli oscuri labirinti dell’anima […] può infine ricondurci alla “visione delle essenze”, che è il fine ultimo di ogni gnosi: l’appuntamento con l’Assoluto. Questo breve romanzo – o lungo racconto – è una testimonianza di tale tentativo; in parte, un fedele resoconto».
Con questa sua ultima opera, l’autore barese, già noto come fine storico dei movimenti ereticali medievali e degli ordini cavallereschi (tra i suoi numerosi e autorevoli lavori, si citano qui alcuni saggi pubblicati da Besa Editrice: Il risveglio della gnosi nella Francia albigese [2001]; I Templari. Storia e leggenda [2004]; I Catari. Dai roghi di Colonia all’eccidio di Montségur [2011]; Insediamenti cavallereschi in Puglia. Templari, Teutonici, Ospitalieri [2015]), esordisce come narratore, benché queste sue Lettere non siano propriamente classificabili come un romanzo epistolare – almeno secondo i canoni letterari convenzionali. Si tratta piuttosto di una sorta di breve diario di viaggio composto nell’Erg del Ténéré, un journal intime le cui annotazioni coprono poco meno di due mesi estivi, dal 14 luglio all’11 settembre 2014, con l’aggiunta in appendice di una pagina non datata redatta presso Villeneuve-sur-Lot (Midi-Pyrénées), comune della Francia meridionale.
La trama si può ricostruire scandagliando i soliloqui in interiore homine di Adrien. L’uomo (sulla cui identità biografica il lettore apprende solo scarse informazioni), prostrato dalla morte improvvisa della donna amata «in un terribile incidente», trascorre «dieci anni di anoressia dell’anima» in un nosocomio di Tolone, a ovest della Costa Azzurra. Dimesso dalla clinica, il ricordo della sua Corinne – cui l’opera è dedicata e che è la sola (ideale) destinataria di tutte le missive – non si è affievolito, e neppure lo strazio del distacco. Inizia così un catartico, palingenetico cammino interiore lungo il periplo della sua stessa esistenza in cerca di quell’amore inesorabilmente perduto che lo condurrà a peregrinare principalmente tra le regioni desertiche di Marocco, Algeria e Niger – e tra i fieri abitatori di quei luoghi, sopravvissuti a diversi tentativi di genocidio e a ogni sorta di vessazioni – per poter finalmente rinascere a nuova vita: «Sì, Corinne […] non si viene qui per nascondersi, ma per ritrovarsi. E dovevo farlo, ora che ti ho ritrovata».
Il viaggio di Adrien (personaggio forse ispirato all’Adrian Leverkühn del Doctor Faustus di Thomas Mann), reale o metafisico che sia, si costella di innumerevoli guide: fari delle epoche passate (recenti o lontane), ritrovati nei loro insegnamenti incorruttibili e imperituri consegnati ai posteri, ma anche interlocutori in carne e ossa. Alla prima schiera appartengono eminenti figure sia occidentali sia orientali: da Carl Gustav Jung con il suo Libro Rosso all’autore algerino Malek Haddad; da Ǧalāl al-Dīn Rūmī a Massimo Scaligero (cui si allude implicitamente nel testo come a un «misconosciuto scrittore italiano»); da Ibn ʿArabī (ricavato essenzialmente dai folgoranti studi di Corbin) al Goethe del Faust; dal poeta ceco Vítezslav Nezval al Friedrich Nietzsche dello Übermensch predicato da Zarathustra. Vi sono poi gli ‘incontri’ del protagonista con individui ‘straordinari’ (per dirla con Gurdjieff) tra cui: il ṣūfī Abìd (ʿAbid), illuminato custode dei «segreti della parola»; l’amazigh Yussuf (Yūsuf), campione di dignità, integrità e saggezza; il mistico ḥăsīd Shlomo, «irriducibile giocoliere delle sefīrōt»; l’oniromante e chiaroveggente Khadidja (Ḫadīǧah), fulgido esempio di donna tuareg, forte e indipendente, che indicherà ad Adrien la meta decisiva.
Se è vero che Lettere dal Ténéré risente di molteplici e complesse suggestioni mistico-religiose (connesse non soltanto alle tre maggiori fedi monoteistiche, ma anche all’Animismo, alle credenze preislamiche, allo Zoroastrismo, alla fede indo-buddhista…), Adrien individua principalmente nella gnosi la suprema koinè spirituale, l’unico vero ed eterno ponte tra Occidente e Oriente, la sola via percorribile per l’«Oltreuomo».
Una massima popolare diffusa nel deserto, invero non citata nelle Lettere, recita: «Confida in Dio, ma lega il cammello». Sembra che tale detto, talvolta adoperato in modo simile al nostro proverbio «fidarsi è bene, non fidarsi è meglio», sia tratto in realtà da una parabola ṣūfī che racconta di un maestro in viaggio con un discepolo cui il primo aveva affidato il compito di occuparsi del loro mehari (dromedario o cammello arabo). Giunti una notte presso un caravanserraglio, il discepolo, assonnato e indolente, tralasciò di legare l’animale, limitandosi, prima di coricarsi, a pregare Dio
perché vegliasse su di esso. Il mattino seguente, come è facile immaginare, non vi era più traccia della bestia. All’incauto discepolo, che si giustificava sostenendo di non avere alcuna colpa per l’accaduto, essendosi raccomandato direttamente a Dio di fargli da guardiano, il maestro rispose: «Affidati ad Allāh, ma prima lega il cammello, perché Allāh non ha che le tue mani». Questa parabola potrebbe essere utile a chiarire quella che è forse la principale differenza tra Oriente e Occidente, intendendo i due termini non certo nella loro mera accezione geografico-culturale, ma come grandi categorie umane. Riporre assoluta fiducia in Dio e al contempo rimanere completamente inerti è per certi versi una consuetudine tipicamente ‘orientale’; confidare esclusivamente nelle proprie forze senza nutrire altra fede se non in se stessi è invece l’atteggiamento che sta alla base dell’ipertrofica e ottusa tracotanza ‘occidentale’. Ma esiste una ‘terza via’, insegna la parabola, che è anche quella percorsa da Adrien e che costituisce il significato più autentico dell’amor fati, concezione di ascendenza stoica tanto cara a Nietzsche: vivere in pienezza senza lasciare nulla di intentato e senza sottrarsi alle proprie responsabilità, e poi accogliere con gratitudine e con gioia qualsiasi conseguenza ne potrà derivare.
Tutte le fotografie riprodotte a corredo del presente articolo (alcune delle quali compongono l’apparato iconografico di Lettere dal Ténéré) provengono dall’archivio personale di Paolo Lopane, che ha anche generosamente accettato l’invito alla seguente intervista.
Lettere dal Ténéré si presenta come un’opera iniziatica. Alla stregua dello Zarathustra nietzscheano, si potrebbe definire anch’esso «un libro per tutti e per nessuno». Come è nato un simile progetto?
In realtà, non v’è mai stato alcun progetto; o, perlomeno, non nel senso comunemente attribuito all’espressione. La narrazione ha preso forma quasi da sé in occasione del mio penultimo soggiorno nel Sahara, al confine tra Marocco e Algeria, nell’estate del 2017. Lì è stato concepito il romanzo e sempre lì, fra quelle sabbie, ho composto le prime pagine di un racconto ripreso e ultimato soltanto nel dicembre dello stesso anno, in pochi giorni di lavoro ininterrotto. È un viaggio dell’anima nell’anima, un viaggio a ritroso nella memoria, una testimonianza diretta – ben poco elaborata – di un personale percorso di totalizzazione dell’essere, di cerca (e ricerca) di ciò che Jung chiamò «il Sé» e che nel linguaggio gnostico è il «vero Io». Il protagonista del racconto, Adrien, è un uomo stanco e affamato, affamato d’Assoluto e stanco, mortalmente stanco dei vaniloqui sterili delle accademie, disincantato nei confronti di ogni fede normativa e delle risposte monche della filosofia; e per cercare la radice ultima dell’Io, la radice intima dell’Essere e di ogni essere, Adrien fa saltare a un certo punto ogni ponte e si spinge – la vita stessa lo spinge – in latitudini dello spirito che travalicano anche materialmente l’Occidente e il suo vuoto di senso per riscoprire culture altre, culture del sacro, culture che il mondo globalizzato considera marginali, ma in cui non si è ancora spezzato del tutto l’axis mundi, l’Asse del Mondo, il mitico asse di collegamento fra il Cielo e la Terra… È così che Adrien conosce Abìd, l’uomo che lo inizierà alle mistiche di ogni tempo, all’unità trascendente delle religioni, e si ritrova, anni dopo, nel deserto dei deserti – il Ténéré.
La tradizione gnostica indica due differenti vie per trascendere la dualità. Una è la cosiddetta “via purgativa” (quella ad esempio dello zen o dello yoga), che si fonda essenzialmente sulla pratica della meditazione trascendentale: l’obiettivo è depurarsi dalle proprie sovrastrutture mentali e dalle oscurità della vita mondana, svuotarsi totalmente, diventare nulla, ‘non-sé’, fino alla scomparsa dell’ego, che si fa mero testimone, una sorta di limpido specchio della realtà fenomenica che non conosce giudizio né attaccamento. C’è poi la “via unitiva”, la via del cuore attraverso l’amore, che è quella del monaco, del ṣūfī, il quale, anziché procedere ‘per sottrazione’ nel suo percorso ascetico, tende invece a colmarsi fino a traboccare. Ed è in tal modo che egli perviene a una reductio ad unum in cui Amante, Amato e Amore si fondono e diventano il Tutto. Parafrasando il poeta mistico persiano Hakīm Sanā’i nel suo poema Ḥadīqat al-ḥaqīqah (Il giardino della verità), se un uomo puro unisce due in uno, l’amante unisce tre in uno. In questa unio mystica l’io scompare e resta Dio: per trovare Dio, fine ultimo dell’esistenza umana, bisogna infatti morire a se stessi, raggiungere il fanā’ (la condizione in cui il ṣūfī si eleva in una mistica
unione con Allāh), l’estasi, l’annientamento totale. Perché Adrien, che conosce entrambe le vie, sceglie di intraprendere quella della mistica unitiva?
Non si tratta, propriamente, di due distinte vie. Queste categorizzazioni sono frutto della tendenza occidentale a sezionare e ‘formattare’ dialetticamente qualsiasi aspetto della conoscenza, compreso ciò che per sua natura rifugge dalle semplificazioni dialettiche: il mistero del trascendimento di sé, il trascendimento dell’ego per la resurrezione del Sé, lo junghiano «Spirito del profondo». La “via purgativa” e la “via unitiva” rappresentano, in realtà, tappe (o, per così dire, risvolti) di un unico percorso, perché solo nettando e riportando il pensiero alla sua intima scaturigine – la Coscienza pensante –, l’individuo può unirsi alla sorgente primigenia del pensare: il Lógos, che è il Dio vivente. Purificare le forze dell’anima – il pensare, il sentire, il volere – significa muovere consapevolmente verso una tale unione, perché questo anelito, questa liberatoria tensione dell’anima la strappa progressivamente al cono d’ombra che ne vela o ne cela la Luce, la sua intima Luce, svelando la radicale realtà del proprio essere: il Dio nell’Io, l’Amante che si fa Amato, l’Amante che è l’Amato. La liberazione del pensiero dalle sentine del subconscio – l’Ombra di junghiana memoria – è infatti il presupposto stesso dell’Amore, il vero amore, l’amore che si accende nell’anima quando l’anima, il cui tessuto di luce risplende nel fluire del pensare come nell’ordito del sentire, inizia a liberarsi dalle ombre della cerebralità, dallo spirito di avversione, dagli istinti che si convertono in fantasmi di pensiero. Quanto al cammino di Adrien, non v’è dubbio che la forza dell’amore umano, quando non chieda nulla per se stesso e ogni cosa intenda dare, possa rasentare o sconfinare nel Divino. La via dell’amore umano – come ben sapevano (o intuivano) figure come quelle di Dante, Ibn ʿArabī o del poeta bengalese Caṇḍīdās, il cantore della Sahaja – è una vera e propria via di reintegrazione spirituale, un percorso di totalizzazione dell’essere, un viatico per altri cieli e per altri orizzonti. Ma occorre, per questo, trascendere la forma dell’altro, cercare l’altro dove l’altro è, non dove semplicemente appare, elevarlo alla sua cifra metafisica, al suo archetipo celeste, ricondurlo alla sua dimensione cosmica, all’«Uomo Universale» (al-Insān al-kāmil), dionisiacamente frammentato in ogni Io. L’altro è un altro Te stesso, con una storia un po’ diversa.
Alcuni versi del Mas̱nawī di Ǧalāl al-Dīn Rūmī, sommo poeta mistico dell’Islam, recitano: «Se tiriamo una freccia, non siamo noi a farlo: noi siamo soltanto l’arco, l’Arciere è Dio». Essi ricalcano a loro volta il versetto coranico «[…] e non eri tu a lanciar frecce, bensì Dio le lanciava; e questo per provare i credenti con prova buona, poiché Dio è ascoltatore sapiente» (8,17). Nelle Lettere dal Ténéré ricorre invece una citazione da Così parlò Zarathustra: «Io amo gli uomini del grande disprezzo, perché essi sono anche gli uomini della grande venerazione e frecce che anelano all’altra riva». Anche Adrien non si dimostra affatto tenero verso quella che descrive come «un’umanità alla deriva», «una civiltà spiritualmente esangue […] nella sua vana corsa verso il Nulla». Tuttavia la fase più critica della sua vita ha inizio proprio quando egli comprende di non riuscire ad affrancarsi completamente dalla «coscienza necrotizzata dell’Occidente»: «Guardavo al cielo – afferma amaramente – e strisciavo sulla terra». Ed ecco allora che ritornano nelle sue riflessioni i simboli citati: «Sapevo di essere freccia e sapevo di essere l’arco. Ma non sapevo come tenderlo. Non ne avevo ancora la forza, né la consapevolezza. Sapevo solo che c’è un Oltre, e che, al di qua di quell’Oltre, io soffocavo […] sapevo di essere ad un bivio esistenziale – un bivio cosmico, metastorico, al centro della mia parabola umana». Quale forza oscura impedisce agli uomini – perfino nel caso di quelli più consapevoli, più tormentati dalla «nostalgia del ritorno» – di spiccare il volo verso l’Oltre? Quali insegnamenti dovrebbero trarre gli occidentali dall’Oriente per realizzare ciò che Nietzsche definisce il «grande anelito»?
La forza oscura che ci tarpa le ali è quella stessa che impedì a Nietzsche non solo di realizzare, ma anche solo di intuire i retroscena spirituali del suo «grande anelito». Fu questa la sua immane tragedia, la tragedia di una gigantesca figura di pensatore che, mosso dalla radicale forza dello Spirito, finì per avversare, negandola, la forza stessa che lo muoveva. Che cos’era il «Dio Ignoto» al quale dedicò una nota lirica giovanile – il Dio che gli afferrava l’anima «nel profondo» e che voleva «conoscere e servire» – se non la virtualità del Dioniso lacerato e ‘crocifisso’ in ogni anima?
Che cos’era il suo «Oltreuomo» se non l’immagine del ‘Dio nell’Io’, l’archetipo dell’Uomo nuovo, figura della morte di Dio nell’anelito alla resurrezione dell’Io? Perché mai definì il Buddhismo, per il quale ebbe parole di apprezzamento, «religione dell’autoredenzione»? Perché il Buddhismo non delega a un Dio normativo la salvezza dell’uomo… Ma il Cantore di Zarathustra, il Solitario di Sils-Maria, precipitò il suo «Dio danzante» nell’infernale abisso dell’Antiuomo, scaraventandolo dalle sue vette. Ciò che sta affondando la nostra civiltà, ciò che ne segna un declino che pare ormai inarrestabile, è l’inaridirsi della vita spirituale. Ben scrisse Nietzsche, interrogandosi sulla deriva di un’altra civiltà – quella ellenica –, che «un popolo, come, del resto, un uomo, solo di tanto vale, in quanto sappia imprimere sugli eventi della propria vita il sigillo dell’eterno». Di fatto, come ho scritto nella premessa alle Lettere, lungi dal recare impresso il «sigillo dell’eterno», l’Occidente si è smarrito nella divinizzazione del presente, un presente che sub specie saeculi coltiva, canonizza e venera l’evanescenza dell’essere. È in questo desolato scenario, nel vuoto valoriale e nei deserti delle coscienze, che hanno fatto irruzione i nuovi barbari del fondamentalismo – di tutti i fondamentalismi –, surrogati di idee morte nella morte delle Idee. Il pensiero logico – il pensiero dialettico – è senz’altro il fondamento della libertà intellettuale (quindi, della libertà tout court); ma ove si fermi alla propria dimensione cerebrale, ove non sappia attingere alle proprie intime scaturigini e aprirsi il varco a quella «visione delle essenze» che è stato (ed è) il fine di ogni gnosi, finisce per inaridirsi e perdersi nelle secche del relativismo: il relativismo della verità, che è poi il relativismo della morale. Ma il relativismo della verità, figlio di un pensiero disanimato, prosciugato d’ogni linfa spirituale, ha generato il totalitarismo del pensiero unico, la globalizzazione dell’indifferenza, il vuoto di senso del conoscere e dell’esistere: la fine di ogni civiltà. È assai più che il «tramonto dell’Occidente»: è l’eradicazione dell’Umano, è il nietzscheano «deserto che avanza», l’annunziato avvento della «Terra Desolata». Nella metafora ezecheliana, è invero questione dell’inabissamento della luce dello Spirito, della perdita di quella conoscenza trascendente che, sola, può impedire al deserto di farsi strada nelle coscienze. A nulla vale il pensiero anemico di un’intellighenzia déboussolée. La cultura non costituisce un fine in sé. Per dirla con Pavel Nikolaevič Evdokimov, «oggettivata, diviene un sistema di coercizioni, e, in ogni modo, chiusa nei propri limiti, il suo problema è insolubile. Presto o tardi, il pensiero, l’arte, la vita sociale si arrestano al proprio limite, e allora la scelta s’impone: installarsi nell’infinito vizioso della propria immanenza, inebriarsi della sua vacuità o superare le sue strangolanti limitazioni e, in una trasparenza di acque chiare, riflettere il trascendente». La gnosi – la vera gnosi – non è ‘fuga dalla storia’, ma viatico e consapevolezza della sola libertà possibile, della sola via d’uscita possibile: emancipazione da quella che Jung, valicando la prospettiva psicanalitica, aveva eloquentemente definito l’«Ombra»: l’Ombra del Mysterium coniunctionis, l’Ombra di Aiόn, l’Ombra che ha subdolamente trasformato leggi, Chiese e religioni in beffe e trappole e, per dirla con Jacques Lacarrière, nel «perpetuarsi di un inganno millenario». Il suo inganno – la sottigliezza dell’Ombra – è nel non farsi riconoscere.
Abìd – capo di una confraternita ṣūfī, la cui zāwiyyah è situata a Rissani, a ridosso del deserto marocchino – è senza dubbio, tra le altre, una delle figure di riferimento più importanti nel cammino spirituale di Adrien. Molti tratti che lo contraddistinguono ricordano quelli di un misterioso personaggio anonimo, compagno e guida di Mosè, di cui parla il Corano (18,59-81). Alcune tradizioni gli attribuiscono l’appellativo di “al-Ḫaḍir” (o anche “al-Ḫiḍr”, letteralmente “il Verde” o “il Verdeggiante”) e la leggenda popolare ne ha fatto un eterno viandante, immortale, sapiente e benefico – nonostante i modi apparentemente bruschi –, che si manifesta all’improvviso, in sogno oppure nella vita ordinaria, per aiutare i buoni. Nelle Lettere dal Ténéré Abìd viene infatti descritto come «una di quelle rare creature che il destino ti mette davanti per farti crescere, per farti destare. Non per farti ‘sognare’. Anzi. A volte è duro, intransigente, ma capisci che nel suo modo di essere, nelle sue apparenti brume caratteriali, splende sempre una luce d’amore». Si dice inoltre che al-Ḫaḍir sia il capo soprannaturale della gerarchia mistica (secondo certe correnti ṣūfī egli sarebbe superiore perfino al Profeta Muḥammad, tanto che esiste una ṭarīqah risalente al XVIII secolo denominata Ḫaḍiriyyah, fondata sulla sua sola autorità da parte di uno šaiḫ marocchino),
iniziatore alla verità mistica, alla realtà soggiacente al mondo delle apparenze. L’illustre orientalista Henry Corbin sostiene per l’appunto che al-Ḫaḍir «emancipa dalla religione letterale» e «conduce ognuno alla sua propria teofania», poiché egli è l’immagine stessa della metamorfosi, la forma apparente assunta dallo spirito di santità. E così anche la gnosi di Abìd («lui che rispetta tutte le forme è andato oltre ogni forma» commenta Adrien) riflette la relatività della percezione umana e realizza la forma del Nome nascosto di Dio, cui si collegano la santità e le scienze mistiche. Si tratta di un’interpretazione forzata, oppure esiste una reale affinità tra queste due figure?
Come affermò Clemente Alessandrino, «il vero gnostico non possiede la gnosi, il vero gnostico è la gnosi»; e il ṣūfī Abìd, gradualmente assurto alla vera gnosi – la «conoscenza che rende liberi» –, si è portato ai confini del mesocosmo, ossia nel ‘luogo’ della coscienza in cui lo Spirito può rivelarsi attraverso immagini: come, appunto, quella di al-Ḫaḍir, il «fanciullo» di Dio che Allāh, nella sura XVIII del Corano, dice istruito nella «Nostra scienza» e che nel sufismo moderno è ancora indicato quale ispiratore degli Afrād, gli «Spirituali» o «Solitari». Si tratta di un’enigmatica figura che la tradizione islamica identifica con il profeta Elia e che, immortale rappresentante della tradizione primordiale, vaga sulla Terra illuminando e ridestando gli «uomini di Dio». Per quanti possano udirlo, egli parla nei pensieri e può manifestarsi in forma angelica. È un veicolo della Verità vivente, di quella conoscenza sorgiva che rampolla nella luce del pensiero e, quale atto intuitivo immediato, traluce nella poesia ṣūfī nell’espressione al-naẓar, che è il diretto vedere contrapposto a al-ḫabar, il semplice ‘avere notizia’. Una cosa è l’apprendimento razionale, altra la conoscenza metarazionale. Abìd conosce bene al-Ḫaḍir.
La «santa, benedicente, immacolata bellezza» di Corinne – la cui immagine nelle Lettere viene accostata a quella della «Ragazza del Ponte Cinvat» (il Cinvat-Peretu dell’Avestā, menzionato anche dal mistico persiano Suhrawardī, che segna il passaggio tra il mondo terreno e quello celeste) e della stessa Vergine Maria, fino a farsi sembiante dell’Eterno Femminino – è rivelazione di Dio, «un Dio che feconda e nutre, è Padre e Madre, è Uomo e Donna, ed è ovunque». Corbin, nella sua lettura in chiave teosofica dell’opera di Ibn ʿArabī spiega che la «tenera e amabile fanciulla» celebrata dal grande poeta e mistico arabo altro non sarebbe se non la figura teofanica della Sophia aeterna: attraverso «l’immaginazione» si può infatti cogliere la presenza divina nel mondo dei fenomeni e di conseguenza anche un amore ‘profano’, umano, possiede in potenza tutti i requisiti per diventare viatico per l’amore divino. Questa «immaginazione creatrice» (per citare ancora una celebre espressione corbiniana riferita a Ibn ʿArabī) appartiene anche ad Adrien? Si potrebbe sostenere che sia stata proprio la perdita della donna amata – e la conseguente «fiumana di dolore» – ad accrescere in lui la sfera percettiva e dunque anche il suo «mondo immaginale»?
Se Teseo sconfigge il Minotauro ed esce infine dal labirinto, è grazie al filo di Arianna, al coraggio di lei, alla forza sacrificale del suo amore. E se, in un altro celebre mito, la lira di Orfeo viene incastonata in cielo per volontà di Zeus, non è per la bellezza struggente della sua musica, ma perché la lingua già fredda del poeta tracio, ormai spirante, continuava a ripetere tra i flutti il nome della sua Euridice. Corinne continua ad essere, ad attendere Adrien all’ingresso del Ponte Cinvat. Adrien può vederla, inabissarsi «nel segreto di lei», e ripetere con al-ʿAlawī, il poeta di Mostaganem: «Anche se la prossimità si cancella, nella sua sussistenza io sussisto per sempre».
Dialoghi Mediterranei, n. 35, gennaio 2019
Francesco Medici, membro ufficiale dell’International Association for the Study of the Life and Work of Kahlil Gibran (University of Maryland, USA), è tra i maggiori esperti e traduttori italiani dell’opera gibraniana, nonché autore di vari contributi critici su altri letterati arabi della diaspora tra cui Ameen Rihani, Mikhail Naimy ed Elia Abu Madi. Si è inoltre occupato di letteratura italiana moderna e contemporanea, in particolare di Leopardi, Pirandello e Luzi. Docente di materie letterarie nella scuola secondaria, lavora attualmente in un CPIA di Bergamo come insegnante di italiano L2.